Sergej Ejzenstejn, regista magistrale e pioniere della
sperimentazione nel campo del montaggio cinematografico, così scriveva
nel 1929: «Non è questo forse il procedimento dell'ideogramma che
combina l'immagine indipendente della “bocca” e il simbolo dissociato
del “bambino” per dare il significato di “strillo”? Non è questo
esattamente quello che facciamo noi cineasti nel tempo, come Sharaku
nella simultaneità, quando creiamo una mostruosa sproporzione tra le
parti d'un fatto che si svolge normalmente, smembrandolo di colpo in
“un primo piano di mani che si torcono”, in “piani medi di lotta”, e
“primissimi piani di occhi sbarrati”, disintegrando col montaggio il
fatto su piani diversi?» .
Erano le basi del cosiddetto jumpcut, termine che poi è stato preso in prestito dalla materia urbanistica per indicare un fenomeno che proprio in quegli anni conosceva il suo stato larvale. Coeva è difatti la pubblicazione di Urbanisme e Vers une Architecture, testi nei quali Le Corbusier ebbe modo di teorizzare la sua definitiva scomunica della rue corridor a favore di un modello di città in cui volumi edilizi salubri ed efficienti “scordano” il rapporto con la strada e “stanno” nello spazio, rovesciandone le gerarchie che lo connotavano negli insediamenti compatti.
Richard Ingersoll si diverte nel creare un fotomontaggio in cui un’automobile è inserita nella “scena tragica” di Sebastiano Serlio , valutandone il corto circuito che questa semplice azione innesca, per il quale la prospettiva della scena fissa viene snaturata e lo spazio di facciate, piazze e vicoli rifiuta questa scomoda ingerenza.
Molto più a suo agio si trova invece l’auto nelle bretelle, nelle tangenziali, nelle circonvallazioni, in queste infrastrutture di “decompressione” centrifuga del traffico veicolare, pellicola di asfalto ai lati della quale lo sprawl si manifesta in tutta la sua “allucinata normalità” , per dirla alla Koolhaas: il ritmo che prima era serrato e costante diventa sincopato e “sedato”, le enclavi residenziali, commerciali o di qualsiasi altra funzione, risucchiano e rigettano il vuoto urbano contribuendo alla dispersione di ogni presunta logica misuratrice. L’impressione è che la città diffusa, la città generica o in qualunque altro modo la si voglia chiamare, smarrisca identità man mano che la sua densità si fa più rarefatta, secondo meccanismi per i quali la memoria della città che fu si perde tra i volumi figli delle teorie del Moderno e la parcellizzazione privata e selvaggia del territorio suburbano.
La direzione che buona parte degli studi sul tema urbano ha intrapreso ormai da trent’anni a questa parte punta dunque a restituire consistenza teorica e fisica agli insediamenti, nella nuova costruzione come negli interventi sull’esistente; la densità, oltre che presupposto fondamentale, diventa anche strumento progettuale con il quale garantire sostenibilità alle dinamiche di crescita di popolazione urbana che non accennano a diminuire. L’isolato allora si presenta come il “dispositivo urbatettonico” elementare, come cellula costitutiva base attorno alla quale concentrare gli sforzi di ricerca dati la sua persistenza nella forma urbana e in definitiva il suo successo storicamente comprovato rispetto ad altre strutture di insediamento.
continua qui su hortus, rivista di architettura
Erano le basi del cosiddetto jumpcut, termine che poi è stato preso in prestito dalla materia urbanistica per indicare un fenomeno che proprio in quegli anni conosceva il suo stato larvale. Coeva è difatti la pubblicazione di Urbanisme e Vers une Architecture, testi nei quali Le Corbusier ebbe modo di teorizzare la sua definitiva scomunica della rue corridor a favore di un modello di città in cui volumi edilizi salubri ed efficienti “scordano” il rapporto con la strada e “stanno” nello spazio, rovesciandone le gerarchie che lo connotavano negli insediamenti compatti.
Richard Ingersoll si diverte nel creare un fotomontaggio in cui un’automobile è inserita nella “scena tragica” di Sebastiano Serlio , valutandone il corto circuito che questa semplice azione innesca, per il quale la prospettiva della scena fissa viene snaturata e lo spazio di facciate, piazze e vicoli rifiuta questa scomoda ingerenza.
Molto più a suo agio si trova invece l’auto nelle bretelle, nelle tangenziali, nelle circonvallazioni, in queste infrastrutture di “decompressione” centrifuga del traffico veicolare, pellicola di asfalto ai lati della quale lo sprawl si manifesta in tutta la sua “allucinata normalità” , per dirla alla Koolhaas: il ritmo che prima era serrato e costante diventa sincopato e “sedato”, le enclavi residenziali, commerciali o di qualsiasi altra funzione, risucchiano e rigettano il vuoto urbano contribuendo alla dispersione di ogni presunta logica misuratrice. L’impressione è che la città diffusa, la città generica o in qualunque altro modo la si voglia chiamare, smarrisca identità man mano che la sua densità si fa più rarefatta, secondo meccanismi per i quali la memoria della città che fu si perde tra i volumi figli delle teorie del Moderno e la parcellizzazione privata e selvaggia del territorio suburbano.
La direzione che buona parte degli studi sul tema urbano ha intrapreso ormai da trent’anni a questa parte punta dunque a restituire consistenza teorica e fisica agli insediamenti, nella nuova costruzione come negli interventi sull’esistente; la densità, oltre che presupposto fondamentale, diventa anche strumento progettuale con il quale garantire sostenibilità alle dinamiche di crescita di popolazione urbana che non accennano a diminuire. L’isolato allora si presenta come il “dispositivo urbatettonico” elementare, come cellula costitutiva base attorno alla quale concentrare gli sforzi di ricerca dati la sua persistenza nella forma urbana e in definitiva il suo successo storicamente comprovato rispetto ad altre strutture di insediamento.
continua qui su hortus, rivista di architettura
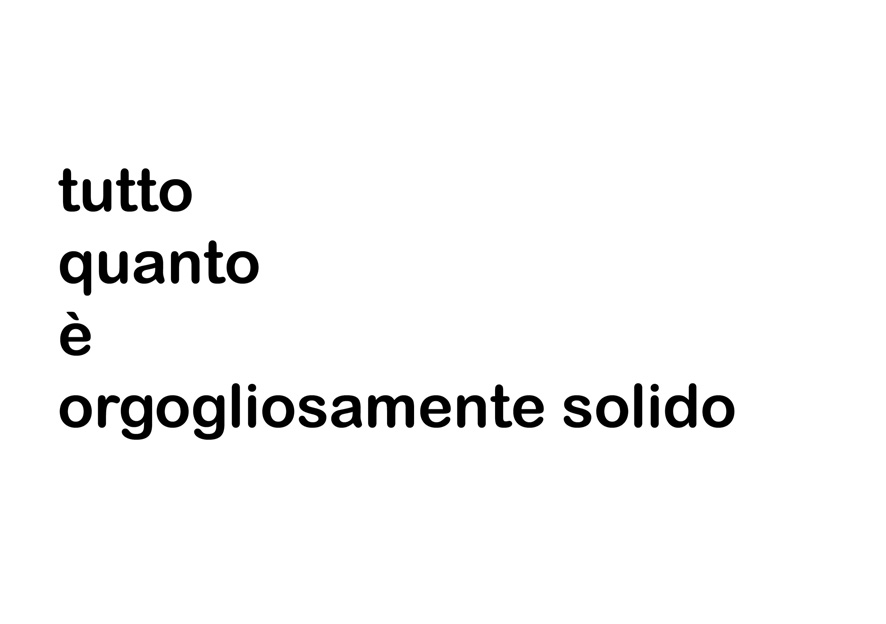

Nessun commento:
Posta un commento